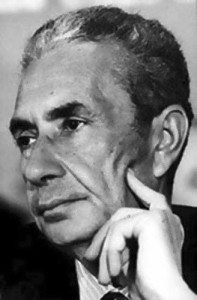Il 18 ottobre del 1951 l’ on. Lelio Basso del partito socialista pronuncia alla Camera un discorso di cui pubblichiamo di seguito uno stralcio:
” Qui siamo in presenza di fatti che sfuggono alla competenza dell’autorita’ giudiziaria; qui non si tratta di sapere che cosa l’autorita’ giudiziaria dovra’ decidere; qui si tratta soltanto di sapere che cosa il ministro decide nei confronti di questi suoi funzionari che hanno prevaricato, che hanno tenuto affettuosa corrispondenza con i banditi a banchetto, che hanno rilasciato documenti falsi affinche’ essi potessero liberamente circolare, che hanno addirittura, come il capitano Perenze, ospitato in casa propria uno di questi, e cio’ non perche’ questi dovesse rendergli dei servigi, ma quando aveva gia’ reso tutti i servigi che doveva rendere. E’ su questi elementi che l’ on. ministro avrebbe dovuto rispondere, e’ su questi elementi che noi ci attendavamo che egli rispondesse”.
Il ministro al quale Lelio Basso si rivolge e’ quello dell’Interno, on.Mario Scelba, e l’antefatto che fa da sfondo e’ quello della strage di Portella della Ginestra. Avvenuta il 1° maggio del 1947 durante un comizio organizzato dal blocco popolare per festeggiare la festa del lavoro, in vista del lancio di una campagna di occupazione delle terre incolte, blocco che veniva da un’ inattesa vittoria alle elezioni regionali del 1947 (29% dei voti). Della strage, nella quale morirono 11 contadini ed altri 65 rimasero feriti, venne ritenuta responsabile la mafia, in combutta con il bandito Salvatore Giuliano.
Si trattava della prima strage di Stato, in cui pezzi delle istituzioni ed esponenti autorevoli della mafia avevano tentato di scoraggiare l’attivismo politico delle masse contadine, lanciando un messaggio forte e chiaro su quale sarebbe stata la risposta dello Stato e dei poteri che governavano allora la Sicilia. A seguito della strage e di altri fatti delittuosi che avevano insanguinato l’isola, come l’attentato ordinato dal capo mafioso Calogero Vizzini contro il parlamentare comunista Girolamo Li Causi e quello contro il socialista Michele Pantaleone il 16 dicembre del 1944 durante un comizio, o come gli assassinii dei sindacalisti agrari Epifanio Li Puma, Placido Rizzotto e Calogero Cangelosi, le opposizioni parlamentari avevano ripetutamente chiesto nel corso delle prime quattro legislature l’istituzione di una Commissione parlamentare d’inchiesta.
L’esigenza veniva dalla necessità di conoscere più approfonditamente non solo i fenomeni della mafia e del banditismo, strettamente legati poiche’ senza il permesso della prima il secondo non sarebbe potuto esistere, ma anche alcune vicende legate alla proprieta’ terriera, agli appalti pubblici, al collocamento dei lavoratori, agli istituti di assistenza e a quelli di credito, giacche’ era piu’ volte emerso trattarsi degli ambiti di potere considerati territorio di conquista delle cosche mafiose.
L’ on. Li Causi aveva inoltre gia ‘ da tempo denunciato, attraverso interventi in aula, l’esistenza di legami evidenti tra la mafia siciliana e il gangsterismo italo-americano, con la presenza sul territorio della penisola di boss mandati al confino o espulsi dagli Stati Uniti del calibro di Frank (tre dita) Coppola, Frank Costello e Lucky Luciano.
Tutti e tre i boss di Cosa nostra americana venivano lasciati indisturbati dalle autorita’ italiane a svolgere tranquillamente i loro traffici di eroina tra l’Italia e gli Stati Uniti.
Il 14 luglio 1950 i giornali annunciano la morte, dopo anni di latitanza, del bandito Giuliano a seguito di uno scontro a fuoco con i Carabinieri. O almeno questa sara’ la versione ufficiale sostenuta dal governo e dalle forze dell’ordine. Unica voce stonata rispetto al coro delle voci mediatiche è quella dell’inviato del settimanale l’Europeo, Tommaso Besozzi, il quale detta per telefono alla sua redazione un pezzo che fara’ la storia del giornalismo italiano, dal titolo: “Di sicuro c’e’ solo che e’ morto”.
Nell’articolo il giornalista scrive come la scena del crimine data in pasto alla stampa, in quel piccolo patio del piccolo comune siculo di Castelvetrano, sia solo una messa in scena ricostruita dai Carabinieri e che Giuliano era stato preso grazie al tradimento del suo fidato braccio destro nonche’ cugino, Gaspare Pisciotta. Quest’ultimo morira’ avvelenato in carcere da un caffe’, la stessa sorte che toccherà qualche anno più tardi a Michele Sindona.
Le circostanze a cui fa riferimento l’on. Basso nel suo intervento alla Camera riguardano il lungo periodo di latitanza di cui ha potuto godere Giuliano, a partire dal suo primo omicidio commesso ad appena 21 anni, quello del carabiniere Antonio Mancino, avvenuto nel settembre 1943.
Secondo le risultanze del processo in corte d’assise svoltosi a Viterbo, in un arco di tempo di 7 anni ( 1943-1950) il curriculum criminale di Giuliano viene segnato da 430 omicidi, in gran parte appartenenti alle forze dell’ordine, commessi in prevalenza durante gli scontri relativi al periodo dell ‘indipendentismo siciliano nell’ immediato dopoguerra, periodo che valse al bandito i galloni di tenente colonnello, comandante dell‘Esercito Volontario Indipendentista Siculo (EVIS).
Omicidi, dunque, ma non solo. Anche rapine e sequestri di persona, commessi ai danni di ricchi agricoltori, commercianti e imprenditori, che fruttano a Giuliano e alla sua banda ingenti risorse economiche (si parlava allora di un miliardo di lire).
L’impegno indipendentista convinto (nel 1946 il MIS abbandona l’illegalita’ per partecipare alle elezioni per l’Assemblea Costituente ) anche da parte della sua famiglia, sia nelle elezioni politiche del 1946 che in quelle regionali del 1947, valgono a Giuliano l’appoggio dell ‘ on. Antonio Varvaro del Movimento Indipendentista Siciliano Democratico Repubblicano (MISDR), ma soprattutto gli consentono di beneficiare a pieno titolo dell’amnistia, concessa nel 1946 dal governo italiano per i reati politici.
Malgrado cio’ Giuliano e la sua banda proseguiranno indisturbati le loro azioni di brigantaggio, fino ad arrivare alla strage di Portella.
Tra le coperture e le complicita’ di cui Giuliano ha potuto godere durante tutto il suo periodo di latitanza, citiamo per prima la mafia. In particolare i boss di Monreale Ignazio Miceli e Benedetto Minasola, ma anche i boss Nino Marotta e Domenico Albano, che fecero da tesorieri nonche’ da carcerieri per le persone sequestrate dal bandito e dalla sua banda.
Sia Gaspare Pisciotta, sia i mafiosi Tommaso Buscetta e Gaspare Mutolo hanno testimoniato in giudizio che Giuliano era stato affiliato alla mafia mediante il rito tradizionale, divenendo lui stesso uomo d’onore.
Ma come sottolineato da Basso nel suo intervento, Giuliano ha potuto godere di ben altri appoggi, politici soprattutto. Nella relazione della Commissione parlamentare antimafia della 5a legislatura, avente ad oggetto i legami tra la mafia ed il banditismo in Sicilia, emerge come Giuliano in una lettera inviata al quotidiano del partito comunista l’Unita’ abbia rivelato di avere avuto rapporti diretti con il ministro dell’Interno, on. Mario Scelba.
Sempre dagli atti della Commissione parlamentare antimafia della 5a legislatura, dal testo dell’audizione del colonnello dei carabinieri Antonio Perenze nella seduta del 22 maggio 1969, alla domanda del commissario Bernardinetti secondo cui risultava agli atti che il colonnello Ugo Luca fosse entrato in contatto con Gaspare Pisciotta attraverso il mafioso Benedetto (Nitto) Minasola, Perenze risponde di non avere mai avuto a che fare con quella persona, essendo stato il colonnello Luca a mantenere tale contatto. Tuttavia il Perenze non esclude che il Minasola fosse mafioso, e comunque di essere venuto a conoscenza di ciò solo in un secondo momento. E ancora.
Il commissario Tuccari chiede a Perenze di raccontargli qualche particolare della trattativa tra Luca e Pisciotta, trattativa che condurra’ poi all’uccisione, da parte di Pisciotta, di Giuliano. In particolare Tuccari accenna al rilascio di salvacondotti al Pisciotta, come premio per il suo tradimento di Giuliano. Perenze risponde che quello di Pisciotta fu solo l’ultimo degli episodi di trattativa, e che prima di quello ve ne erano stati tanti altri. Infine, quando Tuccari chiede a Perenze se avesse assistito il colonnello Ugo Luca nel corso della trattativa con Pisciotta, Perenze risponde di essersi adoperato direttamente con Pisciotta, essendo rimasto solo con lui, ospitandolo nella sua casa per diversi giorni per cercare di conoscere da lui quanti piu’ elementi possibili.
Perenze poi racconta di come fosse stato Pisciotta, violando il patto stretto con il colonnello Luca di consegnarlo vivo, ad uccidere Giuliano in quanto, a suo dire, qualcuno aveva rivelato a Giuliano che Pisciotta lo aveva venduto. L’incolumità del Pisciotta veniva dunque messa a serio rischio. La messa in scena della sparatoria, racconta Perenze, aveva lo scopo di salvare Pisciotta da eventuali rappresaglie ed inoltre, non potendo contare piu’ sulla collaborazione di Giuliano, serviva a garantire quanto meno quella del Pisciotta.
Per il tradimento di suo cugino Pisciotta avrebbe ottenuto anche dei soldi, con i quali assicurarsi un buon avvocato. Alla domanda del commissario Bernardetti su cosa avesse da dire in merito a quanto emerso dal processo di Viterbo secondo cui Pisciotta aveva ricevuto una dichiarazione di benservito, di elogio, con la firma non autografa del ministro dell’Interno Mario Scelba, dunque un trabocchetto per spingere Pisciotta a collaborare, Perenze risponde con un: “Mai saputo”, scaricando ogni eventuale responsabilita’ sul colonnello Paolantonio.
Perenze rivela inoltre come il tesserino di confidente, con la firma non autografa del ministro dell’Interno, venisse rilasciato genericamene a tutti i collaboratori.
Infine alla domanda del Commissario Tuccari sulla provenienza dei documenti ritrovati sul cadavere di Giuliano, documenti consegnati in base alle risultanze processuali dal colonnello Luca, Perenze esclude nel modo piu’ assoluto la circostanza, dichiarando di non avere rinvenuto negli indumenti di Giuliano alcun documento.
Anche gli appunti personali di Giuliano, rinvenuti secondo le risultanze processuali tra i suoi indumenti, non verranno mai più ritrovati. Infine Perenze rivela che su tutto quanto era realmente accaduto a proposito di Giuliano e sulle reali modalità della sua morte era sempre stato tenuto informato il procuratore generale dott. Pili. (cm)